Vai al menù contestuale
Pregiat.mo Signor Dottore,
Due anni or sono, lessi nel Giornale d'Italia un sunto del suo articolo [1] pubblicato sulla Rivista di Psicologia (settembre-ottobre 1907) da Lei diretta, sui fenomeni di sinestesia [2] studiati sopra la signorina Nerina U.
In questi giorni, rovistando le mie carte, ho trovato degli appunti da me presi allora coll'intenzione di comunicarglieli. Non potendo resistere al desiderio di porre in atto questo proposito, ho voluto leggere prima il suo dotto articolo per esteso.
La ragione del grande interesse suscitato in me dai suoi studi sulla sinestesia, è che soffro di fenomeni simili a quelli della signorina Nerina U.
La mia esitazione nel comunicarle per iscritto le mie sensazioni, va attribuita all'abitudine, che ho di sentirmi compatire e (per usare le sue stesse espressioni) benevolmente deridere da parenti ed amici, quando mi provo ad esternarle.
Chi era infatti al caso di poterle ammettere e comprendere? Ad eccezione di mia zia, la quale provava fenomeni simili, e di un altro mio congiunto, che mi citò un caso suo di sinestesia auditivo-visiva (il nome di Civitavecchia gli dava la sensazione di stoffa infilzata su tanti sterpi), ad eccezione, dico, di queste due persone, nessuno.
Ed ora eccomi ad esporle i casi miei.
Mi limiterò a citare pochi esempi più nettamente e fortemente sentiti.
Primo fra tutti: la parola domani corrisponde all'odore della cimice in campagna.
Tanto che per me dire: che odore di domani! O: che puzza di cimice! È la stessa cosa.
L'odore di grassi riscaldati in una locomotiva in pressione, equivale alla parola delitto o derelitto.
Antioco al sedano o finocchio cotto.
Giustiniano, alle castagne arrostite e magagnate.
Gaetano sa d'aglio.
Cento altre sensazioni simili si verificano in me, ma sono meno ben caratterizzate e distinte. Certo che pochi sono i nomi che non hanno un odore o un sapore vago, fuggevole, indeterminato.
Ma fin qui si tratta di sensazioni auditivo-olfattive, che anche nella signorina Nerina U. mi sembrano le più frequenti; infatti essa parla spesso di formaggio romagnolo, di intingoli e di arrosti.
Io posso citare pochi esempi di audizioni sapide:
Amilcare è spiccatamente dolce.
Il nome di Amalia mi ricorda lo zucchero mezzo sciolto e granuloso in fondo ad una tazza di caffè e latte e che i ghiotti di dolciumi trangugiano coll'ultimo sorso.
Il nome di Marco è fortemente pepato.
E qui è strano osservare che tanto nella signorina Nerina U. quanto in me, i nomi di Amalia, Amilcare,Gaetano, Marco, ricordano odori e sapori.
Ma il più bello è che Amilcare è dolce per me e acido per la signorina.
Abbiamo ambedue dei nomi, che si ricordano il sedano, ma per la signorina è il nome di Cristina, per me quello di Antioco.
Non mi pare poi che valga la pena di citare una lunga lista di nomi la cui relazione con cibi e odori è tanto maccaronica; quali nel caso della signorina Nerina U., Chiara, Battista, Benedetto, Bibbiana.
E qui mi perdoni se ardisco farle osservare che Biagio ha semplicemente una stretta relazione fonetica con Ghiaccio. E che Veronica è anche il nome di un fiore, molto noto.
Io potrei dire che Gaspare equivale per me agli asparagi (relazione fonetica), Giacomo, cioccolatini (vi è un cioccolato Giacosa), Caterina, mandorle fresche (a Roma si chiamano Caterinone).
Ciò che infine voglio farle rilevare che non solo i nomi propri, ma anche i nomi comuni, possono ricordarmi odori e sapori.
In secondo luogo, che il caso della mia zia e dell'altro mio congiunto, potrebbe far supporre ad una ereditarietà nei fenomeni di sinestesia.
Tengo poi a dichiararle che mai il nome scritto mi ricorda odori e sapori, ma sempre pronunziato e talvolta, come lei dice benissimo, basta che la pronuncia sia endofasica.
Scusi la mia lunga chiacchierata; e nella speranza che, come Ella dice nella chiusa del suo articolo, la conoscenza esatta di fatti diversi possa condurre ad ottenere qualche luce su fenomeni così strani, mi auguro non essermi reso importuno ad aver in qualche modo cooperato al progresso dei suoi studi.
Le sarò grato, se vorrà darmi un cenno di risposta per ogni ulteriore schiarimento.
Con perfetta osservanza,
Dev.mo
Ludovico Chigi
Palazzo Chigi, Corso Umberto, Roma
[1] G.C. Ferrari, Una nuova varietà di sinestesia, in «Rivista di psicologia», 1907, pp. 297-317.
[2] Fenomeno sensoriale/percettivo per cui una stimolazione (uditiva, olfattiva o tattile) viene percepita come due eventi sensoriali distinti ma conviventi.
Nella sua forma più blanda è presente in molti individui, basti pensare alle situazioni in cui il contatto o la presenza di un odore o di un sapore evoca un'altra reazione sensoriale ed è spesso dovuta al fatto che i nostri sensi, pur essendo autonomi, non agiscono in maniera del tutto distaccata dagli altri. Più indicativo di un'effettiva presenza di sinestesia è il percepire uno stimolo (ad esempio il suono) con una reazione netta e propria di un altro senso (ad esempio la vista). Per "forma pura" si intende la sinestesia che si manifesta automaticamente come fenomeno percettivo e non cognitivo. Il fenomeno è volontario, al punto che il sinesteta puro vede i suoni e sente i colori. Spesso la reazione sensoriale è a direzione unica: ad esempio, se si vede una nota musicale come un colore, non è detto che vedendo quel colore la mente evochi quella nota.
Roma, 11 dicembre 1909
Pregiat.mo Signor Dottore,
Due anni or sono, lessi nel Giornale d'Italia un sunto del suo articolo [1] pubblicato sulla Rivista di Psicologia (settembre-ottobre 1907) da Lei diretta, sui fenomeni di sinestesia [2] studiati sopra la signorina Nerina U.
In questi giorni, rovistando le mie carte, ho trovato degli appunti da me presi allora coll'intenzione di comunicarglieli. Non potendo resistere al desiderio di porre in atto questo proposito, ho voluto leggere prima il suo dotto articolo per esteso.
La ragione del grande interesse suscitato in me dai suoi studi sulla sinestesia, è che soffro di fenomeni simili a quelli della signorina Nerina U.
La mia esitazione nel comunicarle per iscritto le mie sensazioni, va attribuita all'abitudine, che ho di sentirmi compatire e (per usare le sue stesse espressioni) benevolmente deridere da parenti ed amici, quando mi provo ad esternarle.
Chi era infatti al caso di poterle ammettere e comprendere? Ad eccezione di mia zia, la quale provava fenomeni simili, e di un altro mio congiunto, che mi citò un caso suo di sinestesia auditivo-visiva (il nome di Civitavecchia gli dava la sensazione di stoffa infilzata su tanti sterpi), ad eccezione, dico, di queste due persone, nessuno.
Ed ora eccomi ad esporle i casi miei.
Mi limiterò a citare pochi esempi più nettamente e fortemente sentiti.
Primo fra tutti: la parola domani corrisponde all'odore della cimice in campagna.
Tanto che per me dire: che odore di domani! O: che puzza di cimice! È la stessa cosa.
L'odore di grassi riscaldati in una locomotiva in pressione, equivale alla parola delitto o derelitto.
Antioco al sedano o finocchio cotto.
Giustiniano, alle castagne arrostite e magagnate.
Gaetano sa d'aglio.
Cento altre sensazioni simili si verificano in me, ma sono meno ben caratterizzate e distinte. Certo che pochi sono i nomi che non hanno un odore o un sapore vago, fuggevole, indeterminato.
Ma fin qui si tratta di sensazioni auditivo-olfattive, che anche nella signorina Nerina U. mi sembrano le più frequenti; infatti essa parla spesso di formaggio romagnolo, di intingoli e di arrosti.
Io posso citare pochi esempi di audizioni sapide:
Amilcare è spiccatamente dolce.
Il nome di Amalia mi ricorda lo zucchero mezzo sciolto e granuloso in fondo ad una tazza di caffè e latte e che i ghiotti di dolciumi trangugiano coll'ultimo sorso.
Il nome di Marco è fortemente pepato.
E qui è strano osservare che tanto nella signorina Nerina U. quanto in me, i nomi di Amalia, Amilcare,Gaetano, Marco, ricordano odori e sapori.
Ma il più bello è che Amilcare è dolce per me e acido per la signorina.
Abbiamo ambedue dei nomi, che si ricordano il sedano, ma per la signorina è il nome di Cristina, per me quello di Antioco.
Non mi pare poi che valga la pena di citare una lunga lista di nomi la cui relazione con cibi e odori è tanto maccaronica; quali nel caso della signorina Nerina U., Chiara, Battista, Benedetto, Bibbiana.
E qui mi perdoni se ardisco farle osservare che Biagio ha semplicemente una stretta relazione fonetica con Ghiaccio. E che Veronica è anche il nome di un fiore, molto noto.
Io potrei dire che Gaspare equivale per me agli asparagi (relazione fonetica), Giacomo, cioccolatini (vi è un cioccolato Giacosa), Caterina, mandorle fresche (a Roma si chiamano Caterinone).
Ciò che infine voglio farle rilevare che non solo i nomi propri, ma anche i nomi comuni, possono ricordarmi odori e sapori.
In secondo luogo, che il caso della mia zia e dell'altro mio congiunto, potrebbe far supporre ad una ereditarietà nei fenomeni di sinestesia.
Tengo poi a dichiararle che mai il nome scritto mi ricorda odori e sapori, ma sempre pronunziato e talvolta, come lei dice benissimo, basta che la pronuncia sia endofasica.
Scusi la mia lunga chiacchierata; e nella speranza che, come Ella dice nella chiusa del suo articolo, la conoscenza esatta di fatti diversi possa condurre ad ottenere qualche luce su fenomeni così strani, mi auguro non essermi reso importuno ad aver in qualche modo cooperato al progresso dei suoi studi.
Le sarò grato, se vorrà darmi un cenno di risposta per ogni ulteriore schiarimento.
Con perfetta osservanza,
Dev.mo
Ludovico Chigi
Palazzo Chigi, Corso Umberto, Roma
[1] G.C. Ferrari, Una nuova varietà di sinestesia, in «Rivista di psicologia», 1907, pp. 297-317.
[2] Fenomeno sensoriale/percettivo per cui una stimolazione (uditiva, olfattiva o tattile) viene percepita come due eventi sensoriali distinti ma conviventi.
Nella sua forma più blanda è presente in molti individui, basti pensare alle situazioni in cui il contatto o la presenza di un odore o di un sapore evoca un'altra reazione sensoriale ed è spesso dovuta al fatto che i nostri sensi, pur essendo autonomi, non agiscono in maniera del tutto distaccata dagli altri. Più indicativo di un'effettiva presenza di sinestesia è il percepire uno stimolo (ad esempio il suono) con una reazione netta e propria di un altro senso (ad esempio la vista). Per "forma pura" si intende la sinestesia che si manifesta automaticamente come fenomeno percettivo e non cognitivo. Il fenomeno è volontario, al punto che il sinesteta puro vede i suoni e sente i colori. Spesso la reazione sensoriale è a direzione unica: ad esempio, se si vede una nota musicale come un colore, non è detto che vedendo quel colore la mente evochi quella nota.
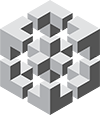




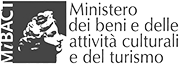


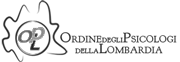
 Quest'opera è distribuita con
Quest'opera è distribuita con