Vai all’inventario
1) Roma, via Montebello 2, 6 dicembre 1919: comunica che il 18 dicembre si radunerà la Commissione plenaria per discutere lo schema delle disposizioni generali del Codice penale da lui presentato, al quale le varie sottocommissioni aggiungeranno le loro proposte parziali. Gli manderà una copia dello schema. Gli invia intanto un ordine del giorno approvato all’unanimità che urge presentare prima del 18 perché la Commissione per la legge sugli avvocati sta concludendo i suoi lavori. Gli chiede quindi di far pervenire il suo voto il più presto possibile. Lo avvisa infine che ha fatto mandare la moglie di un suo cliente a Nozzano [Ville di Nozzano, casa di cura neuropsichiatrica in provincia di Lucca], e che si è messo in contatto con Giovanni Battista Pellizzi.
2) Roma, 6 maggio 1920: avvisa che mercoledì 12 maggio riprenderanno le riunioni della Commissione per la riforma delle leggi penali; spiega che nelle riunioni precedenti hanno esaminato il primo libro del Codice penale e hanno proposto una nuova redazione dell’articolo sui delinquenti pazzi. Per quest’ultimo fisseranno un incontro specifico per permettere a Ferrari e ai colleghi [Alessandro] Lustig, [Sante] De Sanctis e [Salvatore] Ottolenghi di partecipare alla discussione. Confida però che Ferrari partecipi anche ad altre riunioni in cui si esamineranno in seconda lettura argomenti come “delinquenti abituali, minorenni, consigli di patronato, ecc.”, nei quali “l’angolo visuale” degli psichiatri “può dar luogo ad utili rilievi”. Annuncia che prima del 12 gli invierà la nuova versione del primo libro, che sarà pubblicato in autunno, come ha già convenuto con l’onorevole Mortara.
3) Roma, 17 [gennaio] 1921: annuncia che lunedì 24 si radunerà la Commissione per l’approvazione e l’invio alla stampa del Progetto e della Relazione, di cui gli invierà al più presto le bozze. Si stabilirà inoltre in quell’occasione il programma dei lavori per il 1921, prevalentemente giuridici (secondo libro del Codice penale e Processo penale). Sottolinea che per alcuni argomenti (“delitti contro il pudore, ferimenti, aborti, ecc.”) avranno bisogno del loro consiglio e dunque gli farà sapere quando ne discuteranno.
4) Roma, via Montebello 2, 6 aprile 1921: dice di aver letto l’articolo di Renato Serafini sulla sua Rivista di psicologia e chiede a Ferrari di fargli avere una copia del Progetto. Parla della scarsità di copie del medesimo e dice che la stampa sta cominciando a occuparsene favorevolmente, mentre “gli avversari dicono che è un osso duro da mordere”. Comunica che il guardasigilli belga Vandervelde lo farà studiare da una commissione; che il redattore berlinese della Zeitschrift lo annuncerà sabato, lo trova “ottimo per proposte originali” e prevede che a livello internazionale sarà “il beniamino dei progetti di codice penale”. Dice che purtroppo la commissione per il secondo libro si riunirà dopo “il diluvio universale delle elezioni”, alle quali molto probabilmente egli verrà eletto; spera comunque di completare la riforma. Annuncia infine che a fine aprile uscirà l’adesione ufficiale in italiano, francese, inglese e tedesco voluta da Giolitti per “promuovere l’esportazione anche scientifica dell’Italia”.
5) Roma, 6 luglio 1921: in qualità di presidente della Reale Commissione per la riforma delle leggi penali, scrive a Ferrari che durante la seduta del 27 giugno è stata presa in esame la sua lettera del 22 giugno in cui chiedeva che si attuasse un’opera coordinamento tra le istituzioni che si occupano di minorenni. La sua proposta di istituire degli ispettori non spetta però alla commissione, ma al potere esecutivo. La Commissione ha pertanto deciso di richiamare l’attenzione del ministro guardasigilli e del Ministro dell’Interno sulla proposta, affinché prendano provvedimenti.
6) Parma, Albergo Croce Bianca, 25 giugno 1922: chiede se ha ricevuto la lettera con la Relazione da restituirgli e annuncia di essere stato con la signora Chiaroviglio dall’onorevole Dello Sbarba per evitare che le navi-asilo perdano l’indirizzo di educazione che ora hanno. Assicura che l’onorevole radunerà venerdì il Consiglio del Patronato delle navi-asilo e proporrà la nomina a consiglieri degli stessi Ferri e Ferrari; presidente è l’onorevole Luzzatti.
7) Roma, 25 gennaio 1923: essendo riuscito in una pausa lavorativa a leggere il suo saggio “La psicologia della rivoluzione fascista” nella Rivista di psicologia, dichiara di essere sostanzialmente d’accordo con lui, a parte per alcuni dettagli. E per dimostrarglielo gli invia il discorso parlamentare che ha pronunciato nel novembre 1921, “cioè quando del fascismo ben pochi del pubblico in genere e quasi nessuno dei socialisti aveva saputo vedere l’anima profonda”. Il solo appunto che muove al saggio di Ferrari è “di avere dimenticato le benemerenze incontestabili del partito socialista”. Parla poi degli “eccessi del dopoguerra da parte dei socialisti estremi”, del fatto che “il partito socialista in Italia non ha saputo fare la rivoluzione”, dell’intuizione politica di Mussolini “che ha colto il momento di abulia così dei socialisti come dei democratici e ha dato al fascismo una disciplina (di guerra) ed una direttiva”. “L’altro fattore politico del successo fascista” – continua – “sta nella decadenza e degenerazione parlamentare”: egli stesso nel corso della carriera in Parlamento ha provato una progressiva delusione: dai primi tempi di entusiasmo nell’estrema sinistra con il Patto di Roma alla disillusione nel constatare il personalismo soprattutto di Fortis. Dopo averne parlato a lungo con Lombroso, aveva deciso di passare al partito socialista, ma gli ideali politici e sociali si erano poi scontrati con la gerontocrazia parlamentare, ora efficacemente combattuta dal fascismo. E’ convinto che il partito socialista debba assumere un atteggiamento di “semplice attesa”, senza intralciare “l’opera immane, a cui si è accinto il governo fascista” e si dice ottimista per il futuro. Quanto ai lavori della Commissione per la riforma delle leggi penali, ne è pienamente soddisfatto, perché opera anch’essa “alla ricostruzione d’Italia e della civiltà umana”.
8) Roma, via Montebello 2, 19 marzo 1924: dice di non aver risposto prima alla lettera di Ferrari del 5 febbraio perché occupatissimo e poi in viaggio. Si congratula per la sua azione entusiastica, anche se non ha fiducia nell’iniziativa privata. Dice di non aver saputo più nulla del Consiglio per le navi-asilo. Annuncia che sarà a Napoli dal 29 aprile al 3 maggio per il Congresso della Società italiana per il progresso delle scienze, dove parlerà della giustizia penale in Italia. Il 5 maggio inizierà invece il Congresso di filosofia e dunque si vedranno a Napoli se Ferrari non si recherà prima a Roma.
NOTE
Carta intestata: “Consiglio / dell’Ordine degli avvocati / di Roma”; “R. Università degli studi / Roma”; “Studio legale / Avv. Prof. Enrico Ferri / Avv. Guido Cassinelli / Roma / Via Montebello n. 2F, 1° e 2° piano / Telefono interprov. 34-32 / 10-960”; “R. Università degli studi di Roma / Facoltà di Giurisprudenza”; “Ministero della Giustizia e degli Affari di culto”; “Camera dei deputati”.
Contenuto
8 lettere e cartoline del giurista, sociologo e politico Enrico Ferri (1856-1929) a Ferrari:1) Roma, via Montebello 2, 6 dicembre 1919: comunica che il 18 dicembre si radunerà la Commissione plenaria per discutere lo schema delle disposizioni generali del Codice penale da lui presentato, al quale le varie sottocommissioni aggiungeranno le loro proposte parziali. Gli manderà una copia dello schema. Gli invia intanto un ordine del giorno approvato all’unanimità che urge presentare prima del 18 perché la Commissione per la legge sugli avvocati sta concludendo i suoi lavori. Gli chiede quindi di far pervenire il suo voto il più presto possibile. Lo avvisa infine che ha fatto mandare la moglie di un suo cliente a Nozzano [Ville di Nozzano, casa di cura neuropsichiatrica in provincia di Lucca], e che si è messo in contatto con Giovanni Battista Pellizzi.
2) Roma, 6 maggio 1920: avvisa che mercoledì 12 maggio riprenderanno le riunioni della Commissione per la riforma delle leggi penali; spiega che nelle riunioni precedenti hanno esaminato il primo libro del Codice penale e hanno proposto una nuova redazione dell’articolo sui delinquenti pazzi. Per quest’ultimo fisseranno un incontro specifico per permettere a Ferrari e ai colleghi [Alessandro] Lustig, [Sante] De Sanctis e [Salvatore] Ottolenghi di partecipare alla discussione. Confida però che Ferrari partecipi anche ad altre riunioni in cui si esamineranno in seconda lettura argomenti come “delinquenti abituali, minorenni, consigli di patronato, ecc.”, nei quali “l’angolo visuale” degli psichiatri “può dar luogo ad utili rilievi”. Annuncia che prima del 12 gli invierà la nuova versione del primo libro, che sarà pubblicato in autunno, come ha già convenuto con l’onorevole Mortara.
3) Roma, 17 [gennaio] 1921: annuncia che lunedì 24 si radunerà la Commissione per l’approvazione e l’invio alla stampa del Progetto e della Relazione, di cui gli invierà al più presto le bozze. Si stabilirà inoltre in quell’occasione il programma dei lavori per il 1921, prevalentemente giuridici (secondo libro del Codice penale e Processo penale). Sottolinea che per alcuni argomenti (“delitti contro il pudore, ferimenti, aborti, ecc.”) avranno bisogno del loro consiglio e dunque gli farà sapere quando ne discuteranno.
4) Roma, via Montebello 2, 6 aprile 1921: dice di aver letto l’articolo di Renato Serafini sulla sua Rivista di psicologia e chiede a Ferrari di fargli avere una copia del Progetto. Parla della scarsità di copie del medesimo e dice che la stampa sta cominciando a occuparsene favorevolmente, mentre “gli avversari dicono che è un osso duro da mordere”. Comunica che il guardasigilli belga Vandervelde lo farà studiare da una commissione; che il redattore berlinese della Zeitschrift lo annuncerà sabato, lo trova “ottimo per proposte originali” e prevede che a livello internazionale sarà “il beniamino dei progetti di codice penale”. Dice che purtroppo la commissione per il secondo libro si riunirà dopo “il diluvio universale delle elezioni”, alle quali molto probabilmente egli verrà eletto; spera comunque di completare la riforma. Annuncia infine che a fine aprile uscirà l’adesione ufficiale in italiano, francese, inglese e tedesco voluta da Giolitti per “promuovere l’esportazione anche scientifica dell’Italia”.
5) Roma, 6 luglio 1921: in qualità di presidente della Reale Commissione per la riforma delle leggi penali, scrive a Ferrari che durante la seduta del 27 giugno è stata presa in esame la sua lettera del 22 giugno in cui chiedeva che si attuasse un’opera coordinamento tra le istituzioni che si occupano di minorenni. La sua proposta di istituire degli ispettori non spetta però alla commissione, ma al potere esecutivo. La Commissione ha pertanto deciso di richiamare l’attenzione del ministro guardasigilli e del Ministro dell’Interno sulla proposta, affinché prendano provvedimenti.
6) Parma, Albergo Croce Bianca, 25 giugno 1922: chiede se ha ricevuto la lettera con la Relazione da restituirgli e annuncia di essere stato con la signora Chiaroviglio dall’onorevole Dello Sbarba per evitare che le navi-asilo perdano l’indirizzo di educazione che ora hanno. Assicura che l’onorevole radunerà venerdì il Consiglio del Patronato delle navi-asilo e proporrà la nomina a consiglieri degli stessi Ferri e Ferrari; presidente è l’onorevole Luzzatti.
7) Roma, 25 gennaio 1923: essendo riuscito in una pausa lavorativa a leggere il suo saggio “La psicologia della rivoluzione fascista” nella Rivista di psicologia, dichiara di essere sostanzialmente d’accordo con lui, a parte per alcuni dettagli. E per dimostrarglielo gli invia il discorso parlamentare che ha pronunciato nel novembre 1921, “cioè quando del fascismo ben pochi del pubblico in genere e quasi nessuno dei socialisti aveva saputo vedere l’anima profonda”. Il solo appunto che muove al saggio di Ferrari è “di avere dimenticato le benemerenze incontestabili del partito socialista”. Parla poi degli “eccessi del dopoguerra da parte dei socialisti estremi”, del fatto che “il partito socialista in Italia non ha saputo fare la rivoluzione”, dell’intuizione politica di Mussolini “che ha colto il momento di abulia così dei socialisti come dei democratici e ha dato al fascismo una disciplina (di guerra) ed una direttiva”. “L’altro fattore politico del successo fascista” – continua – “sta nella decadenza e degenerazione parlamentare”: egli stesso nel corso della carriera in Parlamento ha provato una progressiva delusione: dai primi tempi di entusiasmo nell’estrema sinistra con il Patto di Roma alla disillusione nel constatare il personalismo soprattutto di Fortis. Dopo averne parlato a lungo con Lombroso, aveva deciso di passare al partito socialista, ma gli ideali politici e sociali si erano poi scontrati con la gerontocrazia parlamentare, ora efficacemente combattuta dal fascismo. E’ convinto che il partito socialista debba assumere un atteggiamento di “semplice attesa”, senza intralciare “l’opera immane, a cui si è accinto il governo fascista” e si dice ottimista per il futuro. Quanto ai lavori della Commissione per la riforma delle leggi penali, ne è pienamente soddisfatto, perché opera anch’essa “alla ricostruzione d’Italia e della civiltà umana”.
8) Roma, via Montebello 2, 19 marzo 1924: dice di non aver risposto prima alla lettera di Ferrari del 5 febbraio perché occupatissimo e poi in viaggio. Si congratula per la sua azione entusiastica, anche se non ha fiducia nell’iniziativa privata. Dice di non aver saputo più nulla del Consiglio per le navi-asilo. Annuncia che sarà a Napoli dal 29 aprile al 3 maggio per il Congresso della Società italiana per il progresso delle scienze, dove parlerà della giustizia penale in Italia. Il 5 maggio inizierà invece il Congresso di filosofia e dunque si vedranno a Napoli se Ferrari non si recherà prima a Roma.
NOTE
Carta intestata: “Consiglio / dell’Ordine degli avvocati / di Roma”; “R. Università degli studi / Roma”; “Studio legale / Avv. Prof. Enrico Ferri / Avv. Guido Cassinelli / Roma / Via Montebello n. 2F, 1° e 2° piano / Telefono interprov. 34-32 / 10-960”; “R. Università degli studi di Roma / Facoltà di Giurisprudenza”; “Ministero della Giustizia e degli Affari di culto”; “Camera dei deputati”.
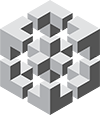





















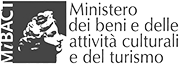


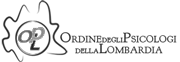
 Quest'opera è distribuita con
Quest'opera è distribuita con