Vai al menù contestuale
Le profonde trasformazioni economiche e sociali che caratterizzarono gli anni a cavallo tra Ottocento e Novecento segnarono un aumento esponenziale del numero di persone affette da disagio mentale in tutta Italia. Furono gli anni del “grande internamento”, in cui i manicomi ospitarono individui ben oltre la loro capienza. In questa fase, anche i manicomi centrali di Venezia a causa del sovraffollamento non poterono più accogliere i malati provenienti dalle zone limitrofe, tra cui Feltre.
Nel 1888 la Deputazione provinciale di Belluno approvò quindi la richiesta di costruzione di un manicomio a Feltre, ampliando il convento di Ognissanti a cui vennero aggiunti circa cento posti letto.
In seguito, con la legge giolittiana n. 36 del 1904 sull’assistenza agli alienati e il successivo regolamento n. 605 del 1909, vennero istituiti i manicomi provinciali. Nel 1911 l’Ospedale civile di Feltre stipulò una convenzione trentennale con l’Amministrazione provinciale di Belluno per l’istituzione di un “sezione manicomiale” per 220 alienati, con retta prefissata per tutti i trent’anni a 1,20 lire a persona (piuttosto bassa, se si pensa che nello stesso periodo a Padova la retta era di 3 lire e a Venezia di 1,60 lire). La firma del contratto con la Provincia impose la costruzione di nuovi padiglioni manicomiali, pertanto nel 1910 venne presentato un progetto per un ulteriore ampliamento della vecchia struttura e l’aggiunta di altri tre padiglioni.
I lavori furono completati solo nel 1917, ma nel frattempo era scoppiata la prima guerra mondiale e Feltre, nel biennio 1917-18, fu occupata dagli austroungarici. In questa fase, l’ospedale non ebbe vita facile, perché poche erano le risorse a disposizione. Nonostante l’iniziale spopolamento del manicomio però, con il ritorno dei soldati dal fronte divenne necessario un ulteriore ampliamento dello stabile, che fu completato nel 1930. I pazienti, intanto, avevano superato i 500 e dal 1921 il dottor Gaspare Gargiulo era diventato il nuovo direttore.
Alla fine degli anni Trenta, dopo l’inaugurazione nel 1938 del nuovo ospedale civile di Santa Maria del Prato in presenza di Benito Mussolini, il complesso di Ognissanti in Borgo Ruga divenne sede esclusiva del manicomio. Negli anni del secondo dopoguerra numerosi degenti vennero trasferiti a Feltre da Padova, dove l’Ospedale psichiatrico fu bombardato, e da Torino, il cui ospedale fu sequestrato e trasformato in ospedale militare, cosicché nel 1946 a Feltre si raggiunse quasi il migliaio di internati.
Con la morte di Gaspare Gargiulo nel 1946, Gino Meneghel divenne il nuovo direttore. “Brillante giornalista, poeta vernacolo, commediografo e romanziere” (A. Rota, 1976, p. 254), Meneghel contribuì ad ampliare considerevolmente l’Ospedale psichiatrico feltrino, ma anche ad accrescerne la fama e l’importanza nel contesto cittadino. In primo luogo, nel 1946 istituì i “dispensari di igiene mentale”, ambulatori esterni in cui egli stesso si recava per offrire servizi gratuiti di visita e diagnosi a chi ne avesse bisogno. In secondo luogo, nel 1948 fece approvare il progetto per la “Casa di salute per malattie nervose e mentali”, dove ricoverare i “dozzinanti”, che potevano permettersi il pagamento della retta manicomiale in cambio di servizi migliori.
Fu però negli anni Cinquanta che si assistette a un ampliamento considerevole dell’Ospedale psichiatrico, sia dal punto di vista strutturale che dell’organico. Nel 1954 venne inaugurato un nuovo padiglione a Pullir, una frazione di Cesiomaggiore a una dozzina di chilometri da Feltre, dove furono alloggiati un centinaio di pazienti tranquilli che venivano impiegati nell’ergoterapia. Con lo stesso scopo, altri pazienti venivano accompagnati quotidianamente da Feltre a Pullir. In seguito, sempre a Pullir, verrà costruito un padiglione femminile per accogliere un altro centinaio di pazienti.
L’Ospedale psichiatrico feltrino arrivò a contare in totale otto padiglioni, a cui si aggiungevano le 15 colonie nelle quali erano impiegati i pazienti psichiatrici, il cui lavoro permise per anni il sostentamento sia del manicomio sia dell’Ospedale civile.
Nel 1952 venne attivato un corso per gli aspiranti infermieri, che doveva essere seguito anche dalle suore. Allo stesso tempo, gli impiegati dell’Ospedale psichiatrico passarono da 108 nel 1946 a ben 161 nel 1954. Era sempre più evidente, dunque, come esso rappresentasse una fonte di lavoro importante per la comunità feltrina.
Sotto la direzione di Gino Meneghel furono introdotte diverse terapie, tra cui l’elettroshock, l’insulinoterapia, la malarioterapia e, a partire dal 1951, la leucotomia prefrontale transorbitaria di Fiamberti, di cui lo stesso Meneghel diede conto nei suoi Contributi neuro-psichiatrici (1955).
Nel giugno del 1955, durante una seduta della Giunta provinciale di Belluno, fu citata una statistica secondo cui Belluno risultava essere al primo posto in Italia per l’incidenza delle malattie mentali, con un rapporto tra i ricoverati e la popolazione dello 0,38% (di 238.269 cittadini, se ne contavano 900 nell’Ospedale psichiatrico), seguita da Varese e Trento (0,25% e 0,24%). Su pressione del direttore e per tentare di risolvere ancora una volta il problema del sovraffollamento, nel 1959 fu ultimata la costruzione del padiglione di osservazione maschile e venne rinnovata la convenzione con la Provincia per altri trent’anni.
Il primo settembre 1968 fu inaugurato il “Padiglione Guarnieri”, ovvero la nuova “divisione per malattie nervose e mentali”. Nel frattempo i degenti avevano superato il migliaio. Per adeguarsi alla cosiddetta “legge Mariotti” dello stesso anno e tentare un ammodernamento dell’istituzione, l’Ospedale psichiatrico feltrino si mise alla ricerca di nuovo personale sanitario e cambiò nome in Ospedale neuropsichiatrico.
Dopo la legge 180 del 1978, che prevedeva la chiusura definitiva degli Ospedali psichiatrici in Italia, ci vollero quasi vent’anni perché quello di Feltre venisse chiuso. In quel lungo periodo fu smembrato in diverse strutture autonome distinte, tra cui la “Casa per ospiti” (una struttura intermedia inaugurata già nel 1979 che proponeva un nuovo metodo riabilitativo e aveva come obiettivo la risocializzazione dei pazienti), un presidio di lungo assistenza (aperto nel 1982 e affidato alla dottoressa Vanda Milano) e il cosiddetto “residuo manicomiale”.
Cecilia Molesini
10/02/2023
Dal Molin, G. (2011). Il cibo nell’ospedale di Feltre nella seconda metà del Novecento. El Campanon, 28, 11-23.
Faronato, G.N. (2002). Santa Maria del Prato: brevi note storiche sull'assistenza psichiatrica a Feltre. Archivio trentino, 2, 83-90.
Grazioli, G. (2020). Il manicomio provinciale di Feltre (1775-1978): follia, controllo sociale e impresa. Archivio storico di Belluno Feltre e Cadore, 366-367, 67-80.
Miscellaneo, S., & Bartolini, D. (a cura di) (2004). L’archivio della Confraternita e ospedale di S. Maria del Prato (1320-1808): per una storia dell’assistenza a Feltre attraverso i documenti delle confraternite. Feltre: Il Fondaco per Feltre.
Rota, A. (1976). Storia dell’ospedale di Feltre. Feltre: Tipografia Castaldi.
Nel 1473, grazie all’unione della “scuola” di San Paolo e quella di Santa Maria del Prato, nacque nel centro di Feltre (Belluno) un ospedale per l’assistenza cittadina. Fu solo nel 1775 però che l’ex convento dei monaci Agostiniani di Ognissanti nel quartiere di Borgo Ruga, soppresso nel 1768 dalla Repubblica di Venezia, divenne la nuova sede dell’Ospedale di Santa Maria del Prato. Inizialmente la struttura aveva dimensioni modeste e contava 25 posti letto, ma col tempo, grazie alle donazioni di diversi benefattori locali, l’ospedale andò incontro a continui ampliamenti, fino a diventare una vera e propria “città nella città”.
Le profonde trasformazioni economiche e sociali che caratterizzarono gli anni a cavallo tra Ottocento e Novecento segnarono un aumento esponenziale del numero di persone affette da disagio mentale in tutta Italia. Furono gli anni del “grande internamento”, in cui i manicomi ospitarono individui ben oltre la loro capienza. In questa fase, anche i manicomi centrali di Venezia a causa del sovraffollamento non poterono più accogliere i malati provenienti dalle zone limitrofe, tra cui Feltre.
Nel 1888 la Deputazione provinciale di Belluno approvò quindi la richiesta di costruzione di un manicomio a Feltre, ampliando il convento di Ognissanti a cui vennero aggiunti circa cento posti letto.
In seguito, con la legge giolittiana n. 36 del 1904 sull’assistenza agli alienati e il successivo regolamento n. 605 del 1909, vennero istituiti i manicomi provinciali. Nel 1911 l’Ospedale civile di Feltre stipulò una convenzione trentennale con l’Amministrazione provinciale di Belluno per l’istituzione di un “sezione manicomiale” per 220 alienati, con retta prefissata per tutti i trent’anni a 1,20 lire a persona (piuttosto bassa, se si pensa che nello stesso periodo a Padova la retta era di 3 lire e a Venezia di 1,60 lire). La firma del contratto con la Provincia impose la costruzione di nuovi padiglioni manicomiali, pertanto nel 1910 venne presentato un progetto per un ulteriore ampliamento della vecchia struttura e l’aggiunta di altri tre padiglioni.
I lavori furono completati solo nel 1917, ma nel frattempo era scoppiata la prima guerra mondiale e Feltre, nel biennio 1917-18, fu occupata dagli austroungarici. In questa fase, l’ospedale non ebbe vita facile, perché poche erano le risorse a disposizione. Nonostante l’iniziale spopolamento del manicomio però, con il ritorno dei soldati dal fronte divenne necessario un ulteriore ampliamento dello stabile, che fu completato nel 1930. I pazienti, intanto, avevano superato i 500 e dal 1921 il dottor Gaspare Gargiulo era diventato il nuovo direttore.
Alla fine degli anni Trenta, dopo l’inaugurazione nel 1938 del nuovo ospedale civile di Santa Maria del Prato in presenza di Benito Mussolini, il complesso di Ognissanti in Borgo Ruga divenne sede esclusiva del manicomio. Negli anni del secondo dopoguerra numerosi degenti vennero trasferiti a Feltre da Padova, dove l’Ospedale psichiatrico fu bombardato, e da Torino, il cui ospedale fu sequestrato e trasformato in ospedale militare, cosicché nel 1946 a Feltre si raggiunse quasi il migliaio di internati.
Con la morte di Gaspare Gargiulo nel 1946, Gino Meneghel divenne il nuovo direttore. “Brillante giornalista, poeta vernacolo, commediografo e romanziere” (A. Rota, 1976, p. 254), Meneghel contribuì ad ampliare considerevolmente l’Ospedale psichiatrico feltrino, ma anche ad accrescerne la fama e l’importanza nel contesto cittadino. In primo luogo, nel 1946 istituì i “dispensari di igiene mentale”, ambulatori esterni in cui egli stesso si recava per offrire servizi gratuiti di visita e diagnosi a chi ne avesse bisogno. In secondo luogo, nel 1948 fece approvare il progetto per la “Casa di salute per malattie nervose e mentali”, dove ricoverare i “dozzinanti”, che potevano permettersi il pagamento della retta manicomiale in cambio di servizi migliori.
Fu però negli anni Cinquanta che si assistette a un ampliamento considerevole dell’Ospedale psichiatrico, sia dal punto di vista strutturale che dell’organico. Nel 1954 venne inaugurato un nuovo padiglione a Pullir, una frazione di Cesiomaggiore a una dozzina di chilometri da Feltre, dove furono alloggiati un centinaio di pazienti tranquilli che venivano impiegati nell’ergoterapia. Con lo stesso scopo, altri pazienti venivano accompagnati quotidianamente da Feltre a Pullir. In seguito, sempre a Pullir, verrà costruito un padiglione femminile per accogliere un altro centinaio di pazienti.
L’Ospedale psichiatrico feltrino arrivò a contare in totale otto padiglioni, a cui si aggiungevano le 15 colonie nelle quali erano impiegati i pazienti psichiatrici, il cui lavoro permise per anni il sostentamento sia del manicomio sia dell’Ospedale civile.
Nel 1952 venne attivato un corso per gli aspiranti infermieri, che doveva essere seguito anche dalle suore. Allo stesso tempo, gli impiegati dell’Ospedale psichiatrico passarono da 108 nel 1946 a ben 161 nel 1954. Era sempre più evidente, dunque, come esso rappresentasse una fonte di lavoro importante per la comunità feltrina.
Sotto la direzione di Gino Meneghel furono introdotte diverse terapie, tra cui l’elettroshock, l’insulinoterapia, la malarioterapia e, a partire dal 1951, la leucotomia prefrontale transorbitaria di Fiamberti, di cui lo stesso Meneghel diede conto nei suoi Contributi neuro-psichiatrici (1955).
Nel giugno del 1955, durante una seduta della Giunta provinciale di Belluno, fu citata una statistica secondo cui Belluno risultava essere al primo posto in Italia per l’incidenza delle malattie mentali, con un rapporto tra i ricoverati e la popolazione dello 0,38% (di 238.269 cittadini, se ne contavano 900 nell’Ospedale psichiatrico), seguita da Varese e Trento (0,25% e 0,24%). Su pressione del direttore e per tentare di risolvere ancora una volta il problema del sovraffollamento, nel 1959 fu ultimata la costruzione del padiglione di osservazione maschile e venne rinnovata la convenzione con la Provincia per altri trent’anni.
Il primo settembre 1968 fu inaugurato il “Padiglione Guarnieri”, ovvero la nuova “divisione per malattie nervose e mentali”. Nel frattempo i degenti avevano superato il migliaio. Per adeguarsi alla cosiddetta “legge Mariotti” dello stesso anno e tentare un ammodernamento dell’istituzione, l’Ospedale psichiatrico feltrino si mise alla ricerca di nuovo personale sanitario e cambiò nome in Ospedale neuropsichiatrico.
Dopo la legge 180 del 1978, che prevedeva la chiusura definitiva degli Ospedali psichiatrici in Italia, ci vollero quasi vent’anni perché quello di Feltre venisse chiuso. In quel lungo periodo fu smembrato in diverse strutture autonome distinte, tra cui la “Casa per ospiti” (una struttura intermedia inaugurata già nel 1979 che proponeva un nuovo metodo riabilitativo e aveva come obiettivo la risocializzazione dei pazienti), un presidio di lungo assistenza (aperto nel 1982 e affidato alla dottoressa Vanda Milano) e il cosiddetto “residuo manicomiale”.
Cecilia Molesini
10/02/2023
Bibliografia
Chierzi, L. (2018). L’Ospedale psichiatrico di Feltre visto dall’interno della struttura. Dolomiti, 4, 58-61.Dal Molin, G. (2011). Il cibo nell’ospedale di Feltre nella seconda metà del Novecento. El Campanon, 28, 11-23.
Faronato, G.N. (2002). Santa Maria del Prato: brevi note storiche sull'assistenza psichiatrica a Feltre. Archivio trentino, 2, 83-90.
Grazioli, G. (2020). Il manicomio provinciale di Feltre (1775-1978): follia, controllo sociale e impresa. Archivio storico di Belluno Feltre e Cadore, 366-367, 67-80.
Miscellaneo, S., & Bartolini, D. (a cura di) (2004). L’archivio della Confraternita e ospedale di S. Maria del Prato (1320-1808): per una storia dell’assistenza a Feltre attraverso i documenti delle confraternite. Feltre: Il Fondaco per Feltre.
Rota, A. (1976). Storia dell’ospedale di Feltre. Feltre: Tipografia Castaldi.
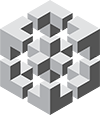







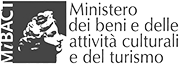


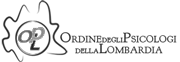
 Quest'opera è distribuita con
Quest'opera è distribuita con