Vai al menù contestuale
È nello stesso periodico, nell’ultimo fascicolo del 1960, che viene chiarito il motivo della nascita della rivista: accostare all’attività della Scuola di formazione specializzata una sezione di studi e ricerche riguardanti i temi che più interessavano la formazione degli educatori e degli assistenti sociali, impegnati nel lavoro di rieducazione di minori con disadattamento sociale. Per tale motivo si può parlare di una rivista scientifica multidisciplinare di stampo giuridico, sociologico, psicologico e pedagogico, con lo scopo principale di indagare e dibattere in merito alla delinquenza minorile, alle sue cause, alle possibili vie di prevenzione e rieducazione, non mancando di sottolineare i percorsi formativi e lavorativi dei professionisti della rieducazione, come educatori e assistenti sociali, anche per ribadirne la necessità e l’importanza a livello sociale, spesso sottaciuta in quegli anni.
Esperienze di rieducazione, oltre ad essere strumento di ricerca e documentazione della scuola specializzata, riesce ad essere anche un periodico di divulgazione per tutti gli esperti del settore, andando oltre alla trattazione di aspetti utili alla formazione e fornendo discussioni anche per i temi caldi della propria contemporaneità, come le normative, che tra gli anni Sessanta e Ottanta hanno rivoluzionato il diritto minorile e i nuovi orientamenti psicologici, sociologici e pedagogici che, sempre in quegli anni, hanno conosciuto una forte evoluzione. La rivista, negli anni di attività, riesce a evidenziare le criticità presenti nel sistema rieducativo italiano e a dibattere circa le soluzioni che a livello teorico ma soprattutto pratico avrebbero portato ad un modo nuovo di intendere il trattamento rieducativo; l’obiettivo primario era convertire un sistema fortemente reclusivo in un sistema incentrato sulla risocializzazione e sui bisogni e diritti dei minori.
Dopo la direzione ventennale di Uberto Radaelli, uno dei protagonisti della giustizia minorile, nel 1974 il testimone passa a un altro personaggio di spicco del settore, il presidente del Tribunale per i minorenni di Roma, Alberto Maria Felicetti. È lui stesso a ribadire, all’inizio del suo mandato, l’impegno «affinché la rivista […] continuasse ad essere un centro di interesse scientifico e un valido punto di riferimento per gli operatori». Nonostante i cambiamenti di periodicità e di direzione, la rivista mantiene negli anni la medesima impostazione per ambiti di riferimento. Nei diversi numeri infatti ritroviamo sempre la divisione in più nuclei tematici, nei quali la redazione ripartisce gli articoli e i saggi; un sistema così ordinato permette una più chiara ricerca e il lettore riesce in questo modo a indirizzare con facilità la lettura sui temi che lo interessano maggiormente: rieducazione in istituto, prospettive medico-psicopedagogiche, giurisdizione minorile, servizio sociale, formazione.
I temi trattati e le novità settoriali discusse sono accompagnate da resoconti su varie esperienze nazionali e internazionali, offrendo alla rivista uno sguardo, una ricerca e un confronto di più ampio respiro. In chiusura dei fascicoli poi sono sempre presenti le sezioni “notiziario” e “biblioteca”: nel primo vengono riportate notizie su convegni e congressi nazionali e internazionali rivolti a magistrati ed educatori, comunicati riguardanti le nuove proposte di legge relative all’ambito minorile e le iniziative formative per gli operatori; la sezione “biblioteca” fornisce la bibliografia di riferimento completa di ogni fascicolo, ma è arricchita anche da brevi descrizioni di volumi, italiani e stranieri, in uscita in quegli anni.
La rivista, sin dall’inizio dei lavori, si circonda di illustri collaboratori per i vari ambiti di interesse: in particolare, per l’ambito giuridico e giudiziario, Gianpaolo Meucci, Alfredo Carlo Moro, Luigi D’Orsi, Giuseppe La Greca e gli stessi direttori Radaelli e Felicetti; per gli studi sociologici ritornano spesso i contributi di Achille Ardigò e Piero Bertolini e per quelli psicologici le ricerche di Renzo Canestrari e Marco Walter Battacchi; accanto a loro figurano i diversi professionisti che quotidianamente si occupano dei minori considerati devianti, con i resoconti della loro attività lavorativa.
Già da questo breve elenco si capisce come la maggior parte degli autori siano uomini. Non mancano tuttavia i contributi di professioniste donne, che però ricoprono maggiormente il ruolo di educatrici, psicologhe, insegnanti e dirigenti; sebbene quindi Esperienze di rieducazione tenti di superare le discriminazioni di genere, le differenze continuano a essere molte, soprattutto a causa dell’ancora presente diversità a livello sociale e istituzionale, che coinvolgeva diverse professionalità. Differenze che non si riscontrano invece per i diversi ambiti di studio, che nella rivista riescono a essere uniformi, soprattutto per quel che riguarda i contributi di carattere giuridico e quelli relativi alle figure professionali nell’ambito rieducativo; inoltre si nota una particolare attenzione anche alle peculiarità della devianza minorile femminile, a quei tempi poco studiata, ai problemi che in quegli anni riguardavano gli istituti rieducativi destinati alle ragazze e al trattamento rieducativo che risultava diverso per i due sessi.
Dopo più di dieci anni di uscite mensili, Esperienze di rieducazione varia la periodicità da bimestrale a trimestrale, fino al 1983, anno in cui la rivista cambia nome per diventare Esperienze di giustizia minorile e nel 1996 Minori, diritti e giustizia, con il nuovo direttore Raffaele Occulto, educatore e presidente dell’Associazione educatori professionali di comunità (AECO). È lo stesso direttore ad affermare che nel 1996 la rivista modifica gli indirizzi editoriali e i contenuti, mantenendo la tradizione culturale ma al tempo stesso allargandosi su orizzonti di più ampio respiro.
Ginevra Chimenti
18/11/2019
Ardigò, A. (1971). Condizione adolescenziale nella società di oggi. Esperienze di rieducazione, 16(1), 60-74.
Breda, R. (1961). La visione della vita attraverso la figura dell’educatore. Esperienze di rieducazione, 6(3), 7-15.
Costa, A. (1969). Apriamo un dibattito su alcuni problemi negli istituti femminili. Esperienze di rieducazione, 14(6), 10-16.
Felicetti, A. M. (1974). Saluto del direttore. Esperienze di rieducazione, 19(1), 5-6.
La Greca, G. (1976). Delinquenza giovanile e intervento del giudice. Esperienze di rieducazione, 21(4), 22-37.
Meucci, G. (1970). Non sono malati. Esperienze di rieducazione, 15(3), 63-66.
Moro, A. C. (1973). Sui diritti dei minori. Esperienze di rieducazione, 18(1), 5-11.
Occulto, R. (1995). Editoriale. Esperienze di giustizia minorile, 13(1), 1-3.
Radaelli, U. (1966). I momenti essenziali del trattamento rieducativo. Esperienze di rieducazione, 11(1), 3-4.
La rivista Esperienze di rieducazione viene fondata a Roma nel 1955, per volontà del magistrato Uberto Radaelli, anche se l’autorizzazione dal Tribunale di Roma per avviare i lavori del periodico arriva solamente con la sentenza n. 5647 nel febbraio 1957. L’edizione è a cura della Scuola per la formazione del personale per la rieducazione dei minorenni, con sede in Via Giulia n.52, a Roma; questo civico in passato ospitava la Società italiana di criminologia, mentre oggi è sede della Direzione nazionale antimafia del Ministero della giustizia.
È nello stesso periodico, nell’ultimo fascicolo del 1960, che viene chiarito il motivo della nascita della rivista: accostare all’attività della Scuola di formazione specializzata una sezione di studi e ricerche riguardanti i temi che più interessavano la formazione degli educatori e degli assistenti sociali, impegnati nel lavoro di rieducazione di minori con disadattamento sociale. Per tale motivo si può parlare di una rivista scientifica multidisciplinare di stampo giuridico, sociologico, psicologico e pedagogico, con lo scopo principale di indagare e dibattere in merito alla delinquenza minorile, alle sue cause, alle possibili vie di prevenzione e rieducazione, non mancando di sottolineare i percorsi formativi e lavorativi dei professionisti della rieducazione, come educatori e assistenti sociali, anche per ribadirne la necessità e l’importanza a livello sociale, spesso sottaciuta in quegli anni.
Esperienze di rieducazione, oltre ad essere strumento di ricerca e documentazione della scuola specializzata, riesce ad essere anche un periodico di divulgazione per tutti gli esperti del settore, andando oltre alla trattazione di aspetti utili alla formazione e fornendo discussioni anche per i temi caldi della propria contemporaneità, come le normative, che tra gli anni Sessanta e Ottanta hanno rivoluzionato il diritto minorile e i nuovi orientamenti psicologici, sociologici e pedagogici che, sempre in quegli anni, hanno conosciuto una forte evoluzione. La rivista, negli anni di attività, riesce a evidenziare le criticità presenti nel sistema rieducativo italiano e a dibattere circa le soluzioni che a livello teorico ma soprattutto pratico avrebbero portato ad un modo nuovo di intendere il trattamento rieducativo; l’obiettivo primario era convertire un sistema fortemente reclusivo in un sistema incentrato sulla risocializzazione e sui bisogni e diritti dei minori.
Dopo la direzione ventennale di Uberto Radaelli, uno dei protagonisti della giustizia minorile, nel 1974 il testimone passa a un altro personaggio di spicco del settore, il presidente del Tribunale per i minorenni di Roma, Alberto Maria Felicetti. È lui stesso a ribadire, all’inizio del suo mandato, l’impegno «affinché la rivista […] continuasse ad essere un centro di interesse scientifico e un valido punto di riferimento per gli operatori». Nonostante i cambiamenti di periodicità e di direzione, la rivista mantiene negli anni la medesima impostazione per ambiti di riferimento. Nei diversi numeri infatti ritroviamo sempre la divisione in più nuclei tematici, nei quali la redazione ripartisce gli articoli e i saggi; un sistema così ordinato permette una più chiara ricerca e il lettore riesce in questo modo a indirizzare con facilità la lettura sui temi che lo interessano maggiormente: rieducazione in istituto, prospettive medico-psicopedagogiche, giurisdizione minorile, servizio sociale, formazione.
I temi trattati e le novità settoriali discusse sono accompagnate da resoconti su varie esperienze nazionali e internazionali, offrendo alla rivista uno sguardo, una ricerca e un confronto di più ampio respiro. In chiusura dei fascicoli poi sono sempre presenti le sezioni “notiziario” e “biblioteca”: nel primo vengono riportate notizie su convegni e congressi nazionali e internazionali rivolti a magistrati ed educatori, comunicati riguardanti le nuove proposte di legge relative all’ambito minorile e le iniziative formative per gli operatori; la sezione “biblioteca” fornisce la bibliografia di riferimento completa di ogni fascicolo, ma è arricchita anche da brevi descrizioni di volumi, italiani e stranieri, in uscita in quegli anni.
La rivista, sin dall’inizio dei lavori, si circonda di illustri collaboratori per i vari ambiti di interesse: in particolare, per l’ambito giuridico e giudiziario, Gianpaolo Meucci, Alfredo Carlo Moro, Luigi D’Orsi, Giuseppe La Greca e gli stessi direttori Radaelli e Felicetti; per gli studi sociologici ritornano spesso i contributi di Achille Ardigò e Piero Bertolini e per quelli psicologici le ricerche di Renzo Canestrari e Marco Walter Battacchi; accanto a loro figurano i diversi professionisti che quotidianamente si occupano dei minori considerati devianti, con i resoconti della loro attività lavorativa.
Già da questo breve elenco si capisce come la maggior parte degli autori siano uomini. Non mancano tuttavia i contributi di professioniste donne, che però ricoprono maggiormente il ruolo di educatrici, psicologhe, insegnanti e dirigenti; sebbene quindi Esperienze di rieducazione tenti di superare le discriminazioni di genere, le differenze continuano a essere molte, soprattutto a causa dell’ancora presente diversità a livello sociale e istituzionale, che coinvolgeva diverse professionalità. Differenze che non si riscontrano invece per i diversi ambiti di studio, che nella rivista riescono a essere uniformi, soprattutto per quel che riguarda i contributi di carattere giuridico e quelli relativi alle figure professionali nell’ambito rieducativo; inoltre si nota una particolare attenzione anche alle peculiarità della devianza minorile femminile, a quei tempi poco studiata, ai problemi che in quegli anni riguardavano gli istituti rieducativi destinati alle ragazze e al trattamento rieducativo che risultava diverso per i due sessi.
Dopo più di dieci anni di uscite mensili, Esperienze di rieducazione varia la periodicità da bimestrale a trimestrale, fino al 1983, anno in cui la rivista cambia nome per diventare Esperienze di giustizia minorile e nel 1996 Minori, diritti e giustizia, con il nuovo direttore Raffaele Occulto, educatore e presidente dell’Associazione educatori professionali di comunità (AECO). È lo stesso direttore ad affermare che nel 1996 la rivista modifica gli indirizzi editoriali e i contenuti, mantenendo la tradizione culturale ma al tempo stesso allargandosi su orizzonti di più ampio respiro.
Ginevra Chimenti
18/11/2019
Bibliografia
Anonimo (1960). L’attività della Scuola di formazione del personale per la rieducazione dei minorenni dall’inizio al 31 Dicembre 1960. Esperienze di rieducazione, 5(1), 49-65.Ardigò, A. (1971). Condizione adolescenziale nella società di oggi. Esperienze di rieducazione, 16(1), 60-74.
Breda, R. (1961). La visione della vita attraverso la figura dell’educatore. Esperienze di rieducazione, 6(3), 7-15.
Costa, A. (1969). Apriamo un dibattito su alcuni problemi negli istituti femminili. Esperienze di rieducazione, 14(6), 10-16.
Felicetti, A. M. (1974). Saluto del direttore. Esperienze di rieducazione, 19(1), 5-6.
La Greca, G. (1976). Delinquenza giovanile e intervento del giudice. Esperienze di rieducazione, 21(4), 22-37.
Meucci, G. (1970). Non sono malati. Esperienze di rieducazione, 15(3), 63-66.
Moro, A. C. (1973). Sui diritti dei minori. Esperienze di rieducazione, 18(1), 5-11.
Occulto, R. (1995). Editoriale. Esperienze di giustizia minorile, 13(1), 1-3.
Radaelli, U. (1966). I momenti essenziali del trattamento rieducativo. Esperienze di rieducazione, 11(1), 3-4.
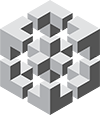





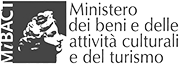


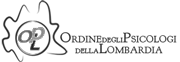
 Quest'opera è distribuita con
Quest'opera è distribuita con