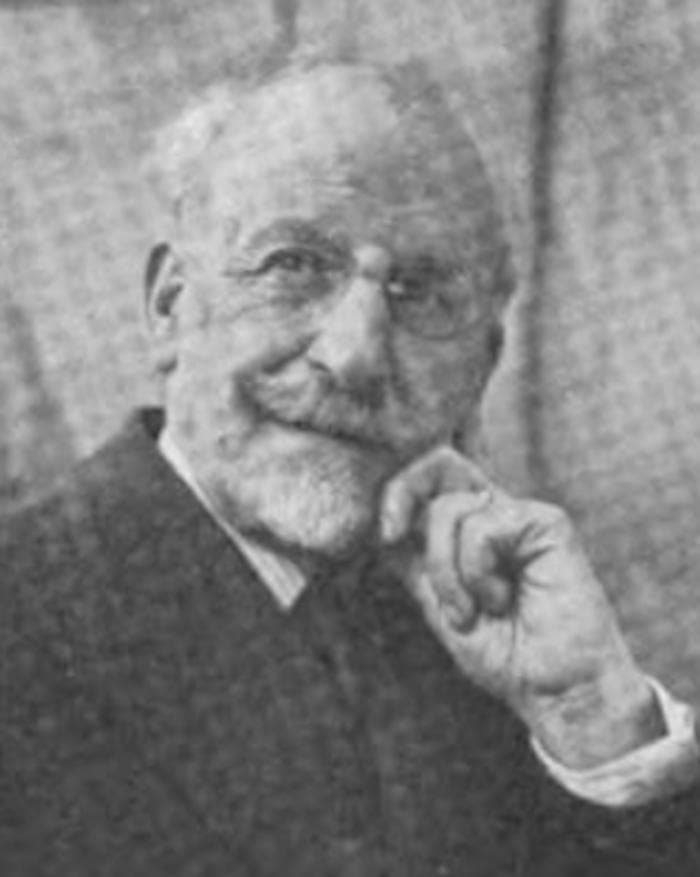
Giuseppe Seppilli
Ancona, 10 dicembre 1851 - Milano, 2 febbraio 1939
Nato ad Ancona da una famiglia di origine ebraica, si laureò in medicina a Bologna nel 1877 con una tesi sulla sifilide cerebrale. Negli anni universitari entrò in contatto con maestri quali Augusto Murri e soprattutto Augusto Tamburini, del quale fu allievo e al cui seguito lavorò sia presso la Clinica psichiatrica dell’Università di Modena, sia presso il Manicomio San Lazzaro di Reggio Emilia. Sempre Tamburini lo chiamò a collaborare alla Rivista sperimentale di freniatria e medicina legale, che vide numerosi studiosi e clinici di valore, formatisi alla scuola reggiana, muovere i primi passi. Seppilli fu redattore della rivista dal 1878 al 1891.
Furono anni, questi, particolarmente intensi per lui dal punto di vista della produzione scientifica – come testimoniano i numerosi saggi da lui pubblicati – e della collaborazione con giovani colleghi, come il pioniere della psicologia italiana Gabriele Buccola, al quale lo legò un rapporto di scambio e di amicizia.
Come sottolineato dagli studi di Carmela Morabito, Seppilli mantenne sempre una stretta connessione tra attività clinica e ricerca sperimentale: perfezionatosi presso i laboratori di Karl Ludwig a Lipsia e di Camillo Golgi a Pavia, durante la sua esperienza a Reggio Emilia collaborò con Tamburini e Luigi Luciani alle ricerche sulla localizzazione delle funzioni cerebrali. Frutto di questi studi fu la pubblicazione, con Luciani stesso, di un corposo volume edito da Vallardi nel 1885, Le localizzazioni funzionali del cervello, che venne poi tradotto anche in tedesco.
Nel 1884 fu chiamato, per volere del direttore Luigi Lolli, come medico capo presso l’Ospedale psichiatrico di Bologna in Imola, dove poté collaborare con altre due giovani leve, Giuseppe Amadei e Silvio Tonnini, distinguendosi per le sue qualità di studioso e di clinico.
Quando nel 1889 la Provincia di Brescia avviò la costruzione del nuovo Ospedale psichiatrico, lo chiamò a coordinarne i lavori, per poi nominarlo, nel 1894, direttore. Mantenne questo incarico per 32 anni, organizzando una struttura all’avanguardia, aperta al territorio (frequenti erano le visite guidate condotte dallo stesso direttore) e in cui particolare attenzione era rivolta all’istruzione del personale sanitario (tra i suoi allievi, va ricordato Aurelio Lui).
Come molti psichiatri della sua generazione, profuse un grande impegno anche nell’organizzazione della pubblica igiene, mostrando attenzione ai problemi sociali del territorio bresciano. A lui si devono la fondazione della Poliambulanza medica e della Lega antialcolica, nonché un forte attivismo nella Lega antitubercolare, nella lotta alla pellagra e nell’istituzione di scuole elementari differenziali per bambini affetti da ritardo. Fu inoltre tra i fondatori, nel 1907, della Società italiana di neurologia.
Durante la prima guerra mondiale si arruolò volontario, assistendo i feriti come ufficiale medico nelle zone di combattimento. L’esperienza lo condusse a elaborare alcune riflessioni sugli effetti psicologici del conflitto, confluite nel 1917 nella pubblicazione I disturbi mentali nei militari in rapporto alla guerra.
Nel 1926 lasciò la direzione dell’Ospedale psichiatrico di Brescia e si ritirò a Milano, dove diresse un ambulatorio di profilassi delle malattie mentali. Posto di fronte alla prospettiva dell’insegnamento, preferì proseguire la sua attività di studioso e di clinico, collaborando tra gli altri con Eugenio Medea presso il Padiglione neuropatologico Biffi dell’Ospedale Maggiore del capoluogo lombardo.
Morì nel 1939, facendo in tempo a sperimentare in prima persona la legislazione antiebraica del regime fascista, come dimostra la richiesta, inoltrata al governo nel novembre 1938, di riconoscimento dello status di perseguitato per sé e per i suoi figli, a cui non ebbe mai risposta.
La sua attività scientifica fu vasta e variegata. Rilevanti i contributi nel campo della neurologia: oltre agli studi sperimentali già ricordati sulle funzioni del cervello, si segnalano le ricerche sui tumori cerebrali, sulla fisiopatologia del simpatico, sulla corea ereditaria e sull’epilessia corticale. Da menzionare anche i suoi studi sull’ipnotismo e il magnetismo, in gran parte ispirati da Tamburini.
Andreas Iacarella
26/02/2021
Furono anni, questi, particolarmente intensi per lui dal punto di vista della produzione scientifica – come testimoniano i numerosi saggi da lui pubblicati – e della collaborazione con giovani colleghi, come il pioniere della psicologia italiana Gabriele Buccola, al quale lo legò un rapporto di scambio e di amicizia.
Come sottolineato dagli studi di Carmela Morabito, Seppilli mantenne sempre una stretta connessione tra attività clinica e ricerca sperimentale: perfezionatosi presso i laboratori di Karl Ludwig a Lipsia e di Camillo Golgi a Pavia, durante la sua esperienza a Reggio Emilia collaborò con Tamburini e Luigi Luciani alle ricerche sulla localizzazione delle funzioni cerebrali. Frutto di questi studi fu la pubblicazione, con Luciani stesso, di un corposo volume edito da Vallardi nel 1885, Le localizzazioni funzionali del cervello, che venne poi tradotto anche in tedesco.
Nel 1884 fu chiamato, per volere del direttore Luigi Lolli, come medico capo presso l’Ospedale psichiatrico di Bologna in Imola, dove poté collaborare con altre due giovani leve, Giuseppe Amadei e Silvio Tonnini, distinguendosi per le sue qualità di studioso e di clinico.
Quando nel 1889 la Provincia di Brescia avviò la costruzione del nuovo Ospedale psichiatrico, lo chiamò a coordinarne i lavori, per poi nominarlo, nel 1894, direttore. Mantenne questo incarico per 32 anni, organizzando una struttura all’avanguardia, aperta al territorio (frequenti erano le visite guidate condotte dallo stesso direttore) e in cui particolare attenzione era rivolta all’istruzione del personale sanitario (tra i suoi allievi, va ricordato Aurelio Lui).
Come molti psichiatri della sua generazione, profuse un grande impegno anche nell’organizzazione della pubblica igiene, mostrando attenzione ai problemi sociali del territorio bresciano. A lui si devono la fondazione della Poliambulanza medica e della Lega antialcolica, nonché un forte attivismo nella Lega antitubercolare, nella lotta alla pellagra e nell’istituzione di scuole elementari differenziali per bambini affetti da ritardo. Fu inoltre tra i fondatori, nel 1907, della Società italiana di neurologia.
Durante la prima guerra mondiale si arruolò volontario, assistendo i feriti come ufficiale medico nelle zone di combattimento. L’esperienza lo condusse a elaborare alcune riflessioni sugli effetti psicologici del conflitto, confluite nel 1917 nella pubblicazione I disturbi mentali nei militari in rapporto alla guerra.
Nel 1926 lasciò la direzione dell’Ospedale psichiatrico di Brescia e si ritirò a Milano, dove diresse un ambulatorio di profilassi delle malattie mentali. Posto di fronte alla prospettiva dell’insegnamento, preferì proseguire la sua attività di studioso e di clinico, collaborando tra gli altri con Eugenio Medea presso il Padiglione neuropatologico Biffi dell’Ospedale Maggiore del capoluogo lombardo.
Morì nel 1939, facendo in tempo a sperimentare in prima persona la legislazione antiebraica del regime fascista, come dimostra la richiesta, inoltrata al governo nel novembre 1938, di riconoscimento dello status di perseguitato per sé e per i suoi figli, a cui non ebbe mai risposta.
La sua attività scientifica fu vasta e variegata. Rilevanti i contributi nel campo della neurologia: oltre agli studi sperimentali già ricordati sulle funzioni del cervello, si segnalano le ricerche sui tumori cerebrali, sulla fisiopatologia del simpatico, sulla corea ereditaria e sull’epilessia corticale. Da menzionare anche i suoi studi sull’ipnotismo e il magnetismo, in gran parte ispirati da Tamburini.
Andreas Iacarella
26/02/2021
Bibliografia
Federico, A. et al. (2011). Le origini e gli sviluppi. 100 anni della Società italiana di neurologia. Siena: SIN.
Fiamberti, A. M. (1954). A professor of neuropsychiatry, Giuseppe Seppilli. Rassegna di studi psichiatrici, 43(6), 1182-1190.
Filippi, M. (1999). Il magnetismo psichico e la sua misura. Rivista di filosofia, 90(1), 17-38.
Medea, E. (1939). Giuseppe Seppilli. Rassegna di studi psichiatrici, 28(1), 182-187.
Morabito, C. (2000). Luigi Luciani and the localization of brain functions: Italian Research within the context of European neurophysiology at the end of the Nineteenth century. Journal of the History of the Neurosciences, 9, 180-200.
Morabito, C. (2018). Seppilli, Giuseppe. Dizionario biografico degli italiani, 92, disponibile online.
Pennacchio, M. (2017). Gli archivi del dolore. Sui militari ricoverati presso il Manicomio provinciale di Brescia (1915-18). Città & Dintorni, 122, 52-68.
Tambroni, R. (1939). Giuseppe Seppilli (1851-1939). Giornale di psichiatria e di neuropatologia, 18, 503-515.
Fiamberti, A. M. (1954). A professor of neuropsychiatry, Giuseppe Seppilli. Rassegna di studi psichiatrici, 43(6), 1182-1190.
Filippi, M. (1999). Il magnetismo psichico e la sua misura. Rivista di filosofia, 90(1), 17-38.
Medea, E. (1939). Giuseppe Seppilli. Rassegna di studi psichiatrici, 28(1), 182-187.
Morabito, C. (2000). Luigi Luciani and the localization of brain functions: Italian Research within the context of European neurophysiology at the end of the Nineteenth century. Journal of the History of the Neurosciences, 9, 180-200.
Morabito, C. (2018). Seppilli, Giuseppe. Dizionario biografico degli italiani, 92, disponibile online.
Pennacchio, M. (2017). Gli archivi del dolore. Sui militari ricoverati presso il Manicomio provinciale di Brescia (1915-18). Città & Dintorni, 122, 52-68.
Tambroni, R. (1939). Giuseppe Seppilli (1851-1939). Giornale di psichiatria e di neuropatologia, 18, 503-515.
Fonti archivistiche
Biblioteca Istituzione Classense, Ravenna, Fondo Giuseppe Amadei.
Biblioteca comunale di Palermo, Archivio Gabriele Buccola (disponibile online su questo portale), Carteggio, Lettere di Giuseppe Seppilli a Buccola, vol. III, n. 4.
Biblioteca comunale di Palermo, Archivio Gabriele Buccola (disponibile online su questo portale), Carteggio, Lettere di Giuseppe Seppilli a Buccola, vol. III, n. 4.
Fonte iconografica
Medea, E. (1939). Giuseppe Seppilli. Rassegna di studi psichiatrici, 28(1), 182-187.